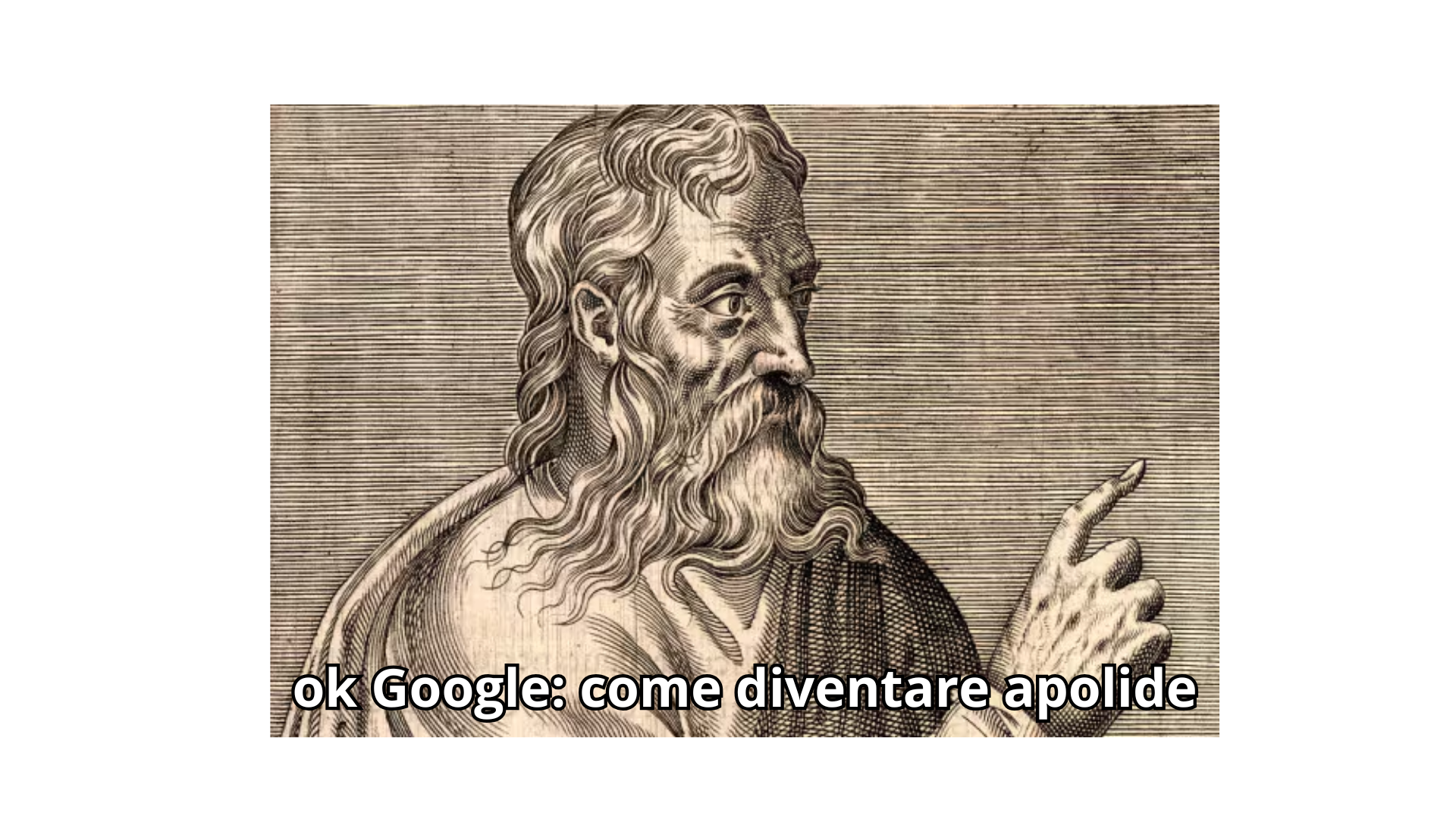
Politica e società
Tutte le strade portano a casa
Licenza Memetica
Tratto dalla rivista N.07
Il senso di identità è delicato come lo scioglimento dello zucchero: basta una minima variazione di temperatura, tempo, superficie a contatto e il risultato cambia da caramello a cristallo, stalattiti o lame affilatissime. Le esperienze di italian* di seconda generazione sono tutte uniche eppure a loro modo uguali, ed è impossibile identificare con certezza i fattori che determinano un sentimento di appartenenza a concetti così complessi come nazione o cultura.
Si è fatto negli ultimi mesi un gran parlare di cittadinanza, di italianità, di ragazzi che “ormai sono più italiani di noi”, di leggi che sarebbero questione di civiltà, ma io vorrei parlare di una serie di cose che il diritto non può carpire, di sfumature, di scomodità e di odori. Ho messo piede in Italia per la prima volta ventidue anni fa, ma per lo Stato non sono ancora italiana, e chissà se mai lo sarò. Ma cosa cambierà una volta ricevuto il verdetto? Cosa cambia nel momento in cui una prefettura prende in mano un lungo fascicolo portante la dicitura “procedura di richiesta di cittadinanza italiana” e decide se la merito o meno?
Grazie a una buona dose di xenofobia interiorizzata mista a infantile fastidio per gli aspetti del mio paese d’origine che non amavo, per molto tempo ho mal sopportato l’essere albanese. Non mi piaceva avere un nome strano, fare lo spelling del mio luogo di nascita, alle elementari non mi piaceva non essere battezzata e non andare a catechismo (col senno di poi: grazie mamma e papà). Sempre da piccola non mi piaceva essere la segretaria di casa, quella che sa bene l’italiano e quindi legge le lettere dell’INPS al babbo.
Tutto quello di cui una volta mi vergognavo ora è parte di chi sono, e soprattutto delle cose in cui credo. La mia identità è anche quel senso di esclusione dalle reti sociali di cui fanno esperienza le famiglie straniere: i genitori dei miei compagni di scuola si conoscevano da decenni, erano amici di famiglia, cenavano insieme, frequentavano le rispettive case e famiglie.
Le radici dei miei amici affondavano nelle radici dei loro genitori che affondavano a loro volta in quelle dei nonni e così via. I miei nonni erano lontani, a malapena sapevano pronunciare il nome della città in cui vivevo, i miei genitori erano solo amici di altri immigrati, incontravano “gli altri” solo ai colloqui con gli insegnanti, e in terza elementare alcuni fecero cambiare scuola ai figli perché in classe c’erano “troppi stranieri”.
A sedici anni, nel capitolo sugli stoici del mio primo libro di filosofia, scoprii l’esistenza degli apolidi: mi precipitai su internet a cercare “come farsi togliere la cittadinanza”, come fosse una specie di malocchio. Dato che non potevo cambiare la mia anagrafica per nascere retroattivamente in Italia, trovai entusiasmante la possibilità quantomeno di non avere alcuna cittadinanza. Purtroppo per la giovane me, il diritto internazionale vieta la revoca della cittadinanza per capriccio adolescenziale, dunque mi arresi a dover appartenere a qualche Stato per sempre.
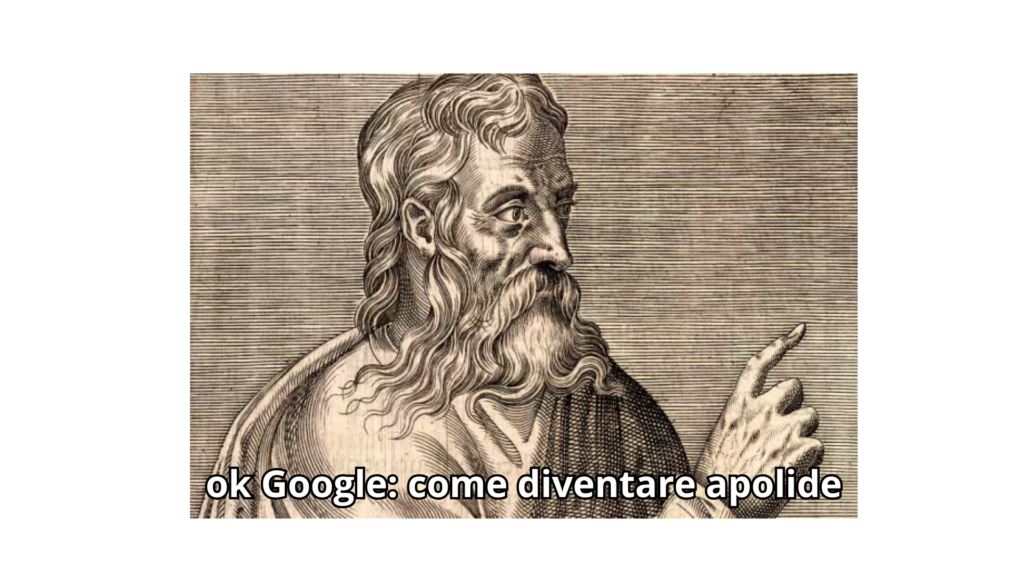
Spero che la prefettura non si offenda, ma se dovessi spiegare da cosa è definita la mia identità, la cittadinanza e l’opinione di una squadra di burocrati non sono nemmeno in classifica. La mia identità è uno spettro di ricordi sfumati. Sono io bambina che nascondo la faccia contro il finestrino singhiozzando perché le vacanze a casa sono finite, perché non mangerò Lays all’origano per un altro anno, perché per un altro anno non compreremo il tè di montagna dai venditori seduti in terra lungo le strade di paese. La mia identità è attraversare quell’unico binario che passa tra la strada e la casa dei nonni, la tappa dal fioraio per comprare i fiori da portare al cimitero, perché la morte è un taboo internazionale, ma anche questa fa parte delle “vacanze” di chi per vacanza intende il ritorno al paese d’origine.

La mia identità è la lenta realizzazione, anno dopo anno, che io pensavo di tornare in un luogo sempre uguale, che chiamavo casa, ma i miei amici d’infanzia crescevano e non mi riconoscevano, quel luogo mi era sempre più alieno, sempre diverso, e non mi aspettava, e viveva e cambiava senza di me. La mia identità è iniziare senza accorgermene a chiamare casa il luogo in cui vivo, lamentarmi dei guai di Firenze con chiunque appena metto piede fuori da questa città, e sorprendermi poi a non vedere l’ora di tornare.
Quando l’autobus mi scarica a Villa Costanza, o il treno in quel pasticciaccio brutto di Santa Maria Novella, smetto di sentirmi in viaggio, eccomi, finalmente stasera dormo nel mio letto, sono tornata.
La mia identità è non avere comunque davvero una casa, essere o l’espatriata o l’immigrata, o l’ospite o la scappata. É quel disagio di bambina nel non conoscere le pratiche casalinghe e familiari dei compagni di scuola, quel non saper tradurre i nomi dei piatti che mangi e allora i tuoi amici chiamano tutto “zuppa”, quel momento di panico quando vai per la prima volta a un funerale cattolico e non sai perché ti porgono la mano dicendo “pace”.

Quando mi chiedono di dove sono rispondo sempre “… è complicato”. Mi piace il modo in cui si pone questa domanda in italiano. Non è come “where are you from”, con quel from che suggerisce una provenienza, non è il “tu viens d’où” francese, col quel viens che disegna uno spostamento. Di dove sei, nella mia esperienza di persona che è di molte parti e pertanto di nessuna, allude più a un’appartenenza, a delle radici lasciate lì ma che portano il mio nome per sempre. Una radice nasce in qualsiasi luogo si pianti un seme, purché il seme sia vivo e il luogo accogliente, ma alcune piante fanno radici nuove anche da adulte, se tagliate nel modo giusto, sia in acqua che in terra, con un po’ di cura.
E allora di dove sono se non di ogni luogo che abbia memoria di me? Il mio nome scritto a mano su un registro dell’anagrafe ventisei anni fa è solo la prima terra che ho toccato, il quartiere 2 che mi ha dato la prima carta di identità da residente fiorentina un’altra terra ancora, la casa in cui sono andata a vivere da sola un’altra ancora, e nessuna terra cancella le precedenti, né il loro ordine cronologico rappresenta una qualche gerarchia.

Ogni volta che mi sono spostata ho lasciato qualcosa indietro, e le mie radici sono così: in tanti luoghi, di diverse forme, di diverse profondità, ma io non posso che elencarle tutte ogni volta, perché sono tutte mie.



