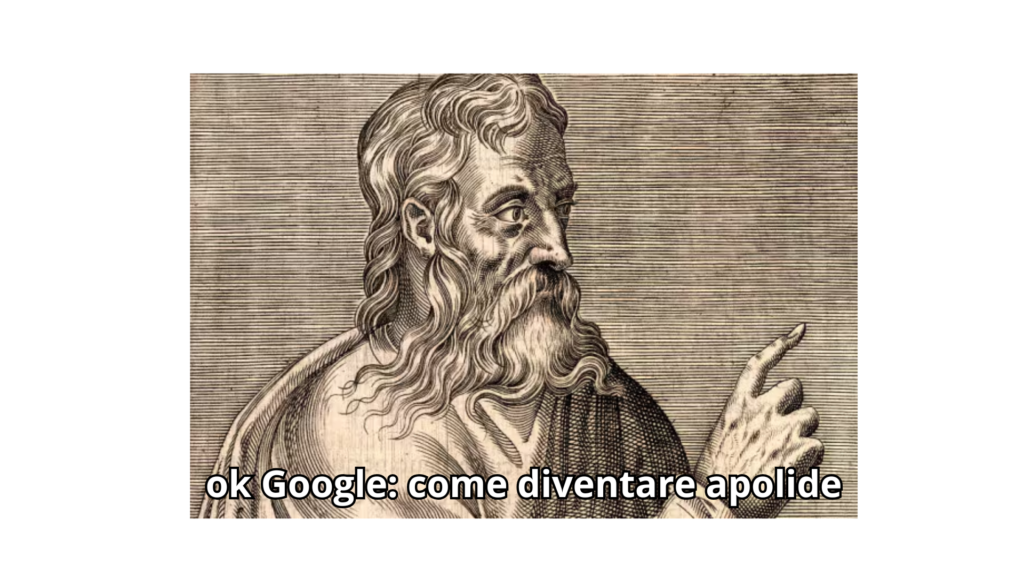Sport
L’orizzonte del calcio è multietnico e giovane
Il gioco del futuro nasce oggi
A cura di
Francesca di Donato
☝🏻 Abbonati a Ratpark Magazine
☝🏻 Condividi se ti è piaciuto!
La multietnicità è, in molti casi, un argomento spinoso. Nonostante le distanze si contraggano, l’accettazione delle diversità culturali è, e sembra rimanere, un ideale che non abita la nostra società. Eppure, esistono situazioni in cui questa supera lo status di concetto teorico per essere una realtà a tutti gli effetti, in grado di apportare cambiamenti e innovazioni. Spicca tra queste, per fama e interesse, il gioco del calcio. Solitamente relegato a dibattiti ben diversi da quello politico, ma che, dal canto suo, ha molto più da insegnare sull’integrazione di molti ambiti istituzionali.
Eternamente tacciato di un carattere inessenziale, il gioco sembra ben distante da un discorso sociopolitico, una monocultura che tutto vuole, fuorché sentire parlare di migrazione. Eppure, sport e internazionalizzazione si muovono insieme sin dal 1800, tempo in cui i viaggiatori inglesi, colonizzatori o soldati che fossero, diffondevano la propria cultura sportiva. O successivamente, durante le grandi emigrazioni degli italiani (e non solo), dove si portava con sé anche il proprio costume sportivo. Tra questi, l’astro del calcio ha brillato più forte di qualunque altro.
L’universalità conquistata da questo sport lo ha reso protagonista di una crescita nella sua dimensione globale, catalizzando i contributi di atleti provenienti dai più disparati angoli del pianeta. Stili di gioco differenti, strategie innovative, hanno ribaltato tanto il piano tecnico quanto il piano sociale, mettendo in campo culture diverse, finalmente in grado di parlarsi. Giocare è così lo sfiorarsi tra culture, un linguaggio che nel tempo si è diffuso e ha permesso qualcosa che sembra tuttora un sogno utopico.
Se parlare di inclusione è troppo ottimistico e rischia di cancellare le ombre di discriminazioni razziali e barriere culturali che le nostre società ancora producono, lo sport apre a una possibilità. L’idea di un’identità di ruolo che riesce a superare quella etnica.
La società nel calcio, Il calcio nella società
Microcosmo di leggi e regole, capace di sospendere giudizi e idee per proporne tutt’altre, il calcio si dimostra in grado di abolire stereotipi, creando immagini del tutto nuove. Ma lo sono davvero? Dopotutto, calcio e società non sono così agli antipodi e lo scontro ideologico non è fuori portata, pur giocandosi su un terreno diverso. Nel 2018, Romelu Lukaku raccontava: “Quando le cose andavano bene, mi chiamavano l’attaccante belga. Quando le cose non andavano bene, ero l’attaccante belga di origine congolese.”
In molti Paesi interessati da consistenti flussi migratori, le nazionali fortemente multietniche sono lo strumento per sottolineare e diffondere idee nazionalpopuliste. I casi fioccano, alla ricerca di un ideale che non può più dirsi attuabile. Ancora una volta, sintomo di un’impossibilità di controllare un cambiamento irrefrenabile. Scegliere di ribadire esattamente chi si è, o chi ci si racconta di essere, è un’alternativa, ma sicuramente non un’alternativa vincente.
A far da maestro è il caso dell’Athletic Club (per l’Italia, erroneamente, Athletic Bilbao), eccezione in un mondo che si rinnova culturalmente, rinunciando all’idea di primeggiare pur di seguire una filosofia identitaria. Dal 1912, infatti, il club accetta solo giocatori provenienti dalle sette province dell’Euskal Herria (il Paese Basco) oppure formatisi nelle giovanili di una squadra basca. Il club e i suoi tifosi sui generis hanno istituito una scala valoriale diversa, tanto da rendere più lieve l’assenza di una conquista di titoli per ben 31 anni. Immolati a un ideale che non porta risultati in termini di vittorie.
La chiave di volta sembra allora essere l’apertura culturale e uno svecchiamento che lasci entrare novità. La natura ubiquitaria del calcio ha permesso uno scambio culturale che va ben oltre la semplice istituzione di competizioni internazionali, quali Coppa del Mondo FIFA e UEFA Champions League. Esiste, al di sotto di questa condivisione partecipativa, un contatto più profondo che lega filosofie culturali e strategie differenti, come possono esserlo il joga bonito brasiliano o il catenaccio italiano. Ed è in questa mescolanza che il gioco si fa più godibile e i risultati presenti. La diversità apre al miglioramento, all’evoluzione.
Laboratori politici
In questo panorama, la Francia si erge a emblema di una selezione estremamente varia di elementi. La storia della nazionale francese ha a che fare tanto con l’origine globale della squadra quanto con i più celebri dibattiti politici. Ma al netto di questi, rimane un dato di fatto: la Francia ha una squadra eterogenea. Proprio questo suo carattere ne ha fatto un idolo nella vittoria del 1998 e un elemento problematico in tempo di sconfitta.
Giudizi scaturiti da una profonda contaminazione politica, così forte da innalzare la squadra a esemplificazione di una natura plurale francese o a esemplificazione di un problema dilagante, a seconda del clima politico. Ma per quanto il dibattito si sforzi, promemoria di una politica così disperata da ideologizzare delle partite, l’alternarsi di una percezione non risulta vincolante. La Francia si dimostra una delle nazionali più titolate, con: due campionati del mondo (Francia 1998 e Russia 2018), due campionati d’Europa (Francia 1984 e Belgio-Paesi Bassi 2000), due Confederations Cup (Corea del Sud-Giappone 2001 e Francia 2003), la Coppa Artemio Franchi 1985 e una UEFA Nations League (2020-2021).
Il calcio ha, così, dimostrato di poter rimanere ciò che è: un punto di contatto tra universi sociali e culturali lontanissimi. Non solo accettazione di una diversità che la politica cerca di seppellire, ma anche ponte per le banlieues, dimostrazione che la multiculturalità è una svolta promettente. Il tutto convogliato in un investimento sulle future generazioni, grazie ai centri di pre-formation, che, si spera, abbiano paure diverse.
A questo proposito, una brevissima parentesi merita il nostro Paese, che soprattutto nella Serie A, di giocatori stranieri ne ha abbastanza. L’Italia sembrerebbe suggerire una contro-tendenza. Ma la falla non è nelle percentuali, bensì nel valore degli atleti e nelle scarse possibilità lasciate ai giovani talenti. La direzione predominante sembra essere quella di acquistare puntando sull’esperienza dei giocatori, sacrificando le qualità tecniche e frenando gli esordienti.
Per la speranza di una vittoria sicura, si accantonano le youth academies, lasciando spazio solo a giocatori navigati. In totale opposizione ai fenomeni di Olanda, Spagna e altri Paesi Europei, abituati a scommettere sulle nuove leve. Al riguardo i dati per il 2024 dell’Osservatorio CIES risuonano limpidi: l’età media della nazionale italiana è 26,34 anni, ben lungi dal primato di 23,05 delle Isole Cayman, seppur vicina alla vetta europea di San Marino con 24,31. Tuttavia, la consapevolezza non manca e la svolta sembra alle porte anche per le squadre più vecchie del nostro Campionato.
Insomma, il mondo cambia e bisogna far spazio al nuovo, dalle nuove generazioni a una definitiva accettazione di quel mix culturale caratteristico della nostra contemporaneità. Seppur la politica sembri recalcitrante in entrambe le direzioni, il gioco del calcio si propone come faro di speranza, memore di un suo specialissimo modo d’essere.
In un’epoca di confini caduti, di comunicazioni invisibili, non ci si può più permettere di immaginare il mondo per divisioni nette e ordinate. Così come non si può immaginare un calcio che tenga in una sua versione statica. Dopotutto, questo, prima di essere puro gioco, è cultura, esperienza di legame, una lingua che si è resa universale, nata da una condivisione e una contaminazione che gli risulta irrinunciabile. Ricordandoci che integrazione non è omologazione, ma la creazione di una cultura delle differenze, che non si cristallizza, bensì evolve e si fonde in modi sempre nuovi. La chiave del successo è nella generazione di una diversità.