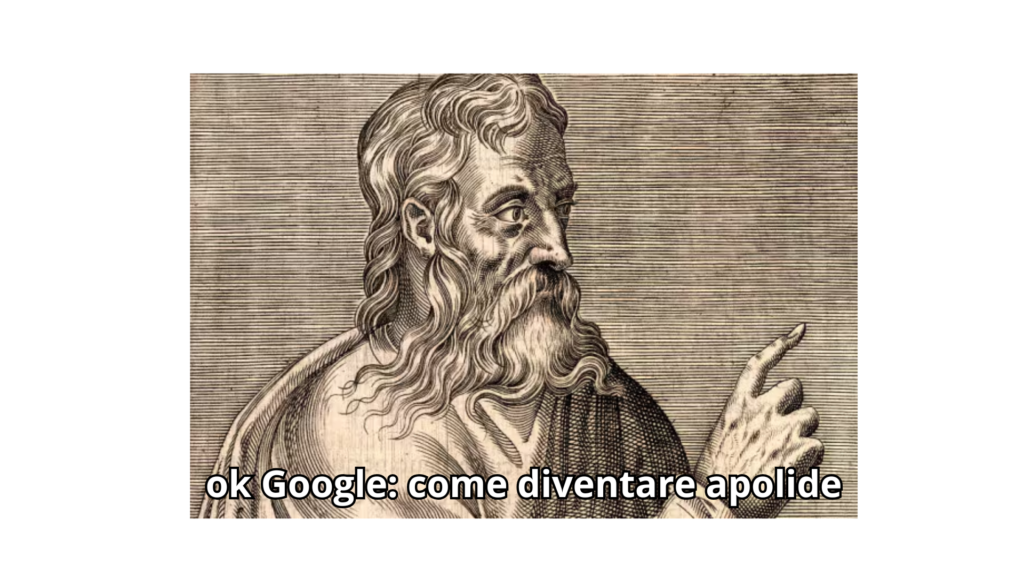Politica e società
Non solo fango
O come l’alluvione di Bologna non ha (ancora) raggiunto i palazzi del potere
Tratto dalla rivista N.08
A cura di
Thomas Cavagna
☝🏻 Abbonati a Ratpark Magazine
☝🏻 Condividi se ti è piaciuto!
Mentre la passerella politica spazzava il tappeto rosso e agghindava le corone, pronta a sfilare nel luogo del delitto a favore di telecamera, abitanti della città, di ogni età e provenienza, già stavano immergendo le mani nel fango. Pala in mano e stivali ai piedi, ci siamo ritrovatɜ nella solidarietà dal basso e nell’autogestione delle energie, del tempo, delle risorse collettive. Lottando contro le scadenze del cielo che ci era crollato addosso, abbiamo liberato i nostri quartieri da una poltiglia che, lo sappiamo bene, ha nomi, cognomi e perfino intenzioni, che ben trapelano dal dato spaventoso sulle precipitazioni del 20 ottobre.
Il primo dato di una lunga lista che non parla solo di piogge e allagamenti, di fanghiglia e detriti, ma parla, grida quasi, di città come terreno (territorio) di battaglia: un conflitto che si inserisce a pieno in questi tempi di guerra, incombendo con sempre più arroganza e costringendoci ai soprusi delle policy scellerate di palazzinari, imprenditori, società intoccabili e innominabili. Soggetti che, strizzando l’occhio a chi detiene il monopolio decisionale sul suolo cittadino, modellano i nostri spazi di vita secondo il capriccio del profitto di pochi e sgretolano ogni centimetro della città dietro la promessa di progetti di riqualificazione che, puntualmente, segregano lo spazio urbano nelle catene delle recinzioni, della logistica del capitale, dei controlli serrati e degli investimenti fini a sé stessi.
Ricorrendo, peraltro, alle solite retoriche trite e ritrite, quelle che vertono sul securitarismo dei manganelli spianati contro chi chiede welfare sociale ed ambientale; sul concetto di decoro come tappeto rosso-sangue da sfoggiare lungo le vie di un centro città a prova di hashtag, ma inavvicinabile ai più; di innovazione come un comodissimo tram (altro che potenziare il trasporto pubblico già in vigore e perennemente intasato!) per reggere l’inutile confronto con metropoli non meglio attrezzate; oltre ai soliti, ampi e improrogabili parcheggi per soddisfare l’iniziativa turistica a discapito di quel polmone verde che, come è ovvio che sia, incassa colpo su colpo, fino a strabordare la sua frustrazione cadendo dal cielo, inondando le strade di fango, giurando di scatenare la sua ira sugli squilibri che ne squarciano la pelle, di politica in politica.

Non sono né il fango né il clima a negare possibilità, risorse e la dignità di avere un tetto caldo e asciutto sopra la testa; a fare tabula rasa dei nostri luoghi d’aggregazione e di tutti quegli spazi comuni, condivisi, in cui trova casa il senso di comunità, in cui la città non è solo rappresentata su carta, ma propriamente vissuta.
Potremmo dire che è la solita vecchia storia: la colpa è di chi trova sempre i soldi per le autostrade, ma i fondi per le case, mai; così come le risorse per investire in un sapere critico capace di immaginare una città a modello dei bisogni della gente, in sinergia con un territorio che è spazio di comunità. Allo stesso modo, i possibili finanziamenti stanziati dal Governo per garantire soluzioni dignitose allɜ sfollatɜ e risarcire i danni materiali di intere attività e abitazioni affondate nel diluvio, non bastano mai.
Questo a dimostrazione che fine del mese e fine del mondo convergono in un’unica lotta, come gridava la Bologna che, solo due anni fa, ha mosso una barricata sociale di oltre 30.000 corpi, bloccando la famigerata tangenziale che si amplierà, su progetto del Comune, con ben diciotto nuove corsie ad insinuare l’asfalto tra caseggiati e campi di granturco, parchi, scuole e terreni selvatici. Quel 22 ottobre del 2022, il movimento delle lotte sociali si è mobilitato in nome della convergenza di forme, pratiche, esperienze precarie, unito dalla pretesa di rompere le catene dello sfruttamento di corpi e territori, ambizioso di assaltare il cielo e riprendersi tutto, pronto a sfidare a testa alta chi, il cielo, ce lo fa cadere in testa.

Lɜ stessɜ precariɜ che, da Bologna e dal resto del paese, hanno imbracciato pale e stivali tendendo la mano alle necessità dellɜ sfollatɜ e dellɜ alluvionatɜ tuttɜ, combattendo in prima linea contro l’abuso dei territori che violenta gli spazi, le case, le comunità. Gli stessi corpi animati dalla rabbia che ha mosso il corteo dei 10.000 Stivali sotto la Regione, rispedendo il fango al mittente, sotto la bandiera di una giustizia sociale che sia giustizia climatica. Riviviamo quegli attimi, coscienti che lo scenario urbano ospita una guerra aperta tra chi indossa gli stivali ai piedi e chi i guanti di velluto che hanno riempito le nostre strade di fango e le proprie tasche di sporco denaro.
Considerando già solo l’estensione dell’autostrada A14, ammonta ad almeno 3,5 miliardi di euro (Comune di Bologna), il (capo)giro di capitale che regge il mercato degli appalti edilizi bolognesi. Investimenti ad almeno nove, dieci cifre, sprecate in assoggettamento del territorio al grigiore del cemento, cantieri su cantieri finanziati dalla cassa pubblica, spacciati come grandi opere da uomini piccoli.
La peggiore burla messa in scena nel teatro di equilibri e conflitti che è la politica cittadina, dove la tragedia (la crisi) è orchestrata da chi veste bene ma razzola male, spergiurando di voler aprire le orecchie alle esigenze della gente. Gli stessi che aprono i portafogli di giovani, lavoratorɜ, famiglie, per sperperare in giri di mancette legalizzate tra potenti della città, nell’illusione dell’efficienza, nella forma di autostrade più larghe e parcheggi multipli dove prima c’era un parchetto di quartiere (vedasi la lotta del Don Bosco); dell’ordine pubblico, come risposta alle questioni sociali, divise dispiegate contro lɜ precariɜ con il fango alle ginocchia e in braccio la pretesa di una città all’insegna del verde e del bene comune, rivendicando una storia fatta di corpi, più che di tratti, corpi coesi in un’unica forma e un’unica sostanza: la rabbia dei margini, schiacciati da emergenze premeditate e lucrose, silenziati dalle passerelle politiche e ridotti a temi scottanti di campagne elettorali insulse.

Un intero sistema che fonda i meccanismi che lo animano sulle logiche di prevaricazione che distruggono chi costruisce. Perché questo emerge con forza dalle nostre storie: la pulsione umana alla costruzione di sinergie e possibilità di riscatto, anche dove il potere, nel suo sbavare imperterrito, ha lasciato solo macerie. E di macerie ne rimangono eccome. Ma (gli) va anche ricordato che, dove prima tutto era fango, a distanza di due settimane dall’incubo, s’è chiacchierato e banchettato, vivendo la strada non come teatro di tragedie, ma come spazio di vita e di socialità, devolvendo più di duemila pasti a sostegno delle famiglie alluvionate tramite l’iniziativa della Piattaforma di Intervento Sociale (PLAT), Bologna4ClimateJustice e del nucleo scout locale.
Dove prima i video ritraevano scene di allagamenti e inondazioni stradali, s’è discusso di crisi climatica con Susanna Corti (Coordinatrice dell’unità di ricerca “Global Change” presso l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del Cnr-Isac), Paolo Ghinassi (ricercato del CNR), Paola Bonora (docente di Geografia UniBo) e Rosanna Foraci (ingegnera idraulica), dando poi spazio all’iniziativa musicale di giovani artistɜ del quartiere.
Via Andrea Costa, tra le più colpite dalla recente alluvione, ha dimostrato che una collettività può riscoprire nella tragedia il mutualismo e l’aggregazione. Migliaia di persone, tra giovani e anzianɜ, famiglie, bambinɜ, studentɜ, lavoratorɜ, precariɜ; accomunatɜ nel comporre un tessuto sociale che si riscopre nella fatica del fango e si fa forza nella rabbia di chi non tollera di veder incombere la crisi climatica sulle proprie teste e sulle proprie case, sulla propria città. Consapevoli che la peggiore Truffa sta proprio in questo: nelle cicatrici mai rimarginate di un territorio che affoga nelle belle promesse di cui si fregiano le cravatte, mentre i nostri stivali affondano nella corruzione e nelle menzogne delle coscienze sporche.
Una cassa che si dice pubblica perché fatta sui corpi, sul tempo e sulle energie della gente, ma elitaria negli interessi e nell’immaginario. Sempre più risorse devolute alla repressione e alla prevaricazione, mentre la precarietà schiaccia la città e marginalizza persone, comunità, esperienze. Un’offesa, questa, a cui dal basso si risponde con l’autogestione e la pretesa collettiva di ripulire le strade dal fango e la città dai fascismi di quartiere e di Governo; contro la violenza del profitto sui territori e sui corpi; lottando per l’autodeterminazione dei popoli e delle soggettività tuttɜ, dal centro alle periferie come dal fiume fino al mare.
Se divise militari e luci blu hanno presidiato coraggiosamente i buffet in dono alle famiglie costrette a dormire in palestre raffazzonate ad alloggi d’emergenza; è vero, di contro, che l’alluvione del 2024 ha rimesso in moto quel meccanismo di spontanea solidarietà che, già nel 2023, aveva raccolto innumerevoli volontariɜ di ogni provenienza, giuntɜ in soccorso dellɜ sfollatɜ e coordinatɜ da cittadinɜ che conoscono il territorio e se ne prendono cura. Perché, anche questa volta, la storia non ci travolge, ma ci costituisce. Come persone, non angeli, che imbracciano le pale decidendo di farne uno strumento di pretesa e di identità collettiva, lasciando l’impronta di una lotta nelle strade segnate dalle alluvioni, perché il fango sia un nuovo inizio e i detriti una barricata.

Nessuna aureola celestiale, nessuna candida piuma ad accogliere la catastrofe, a farne una possibilità di nuovo e diverso. Solo rabbia e la necessità collettiva di organizzarla, per costruire sulle macerie e fare della fine un nuovo capitolo da scrivere, per una città all’insegna del benessere comune e del territorio. Se il fango ha diversi nomi e cognomi, la giustizia sociale ha un’unica bandiera: dal territorio, per il territorio.