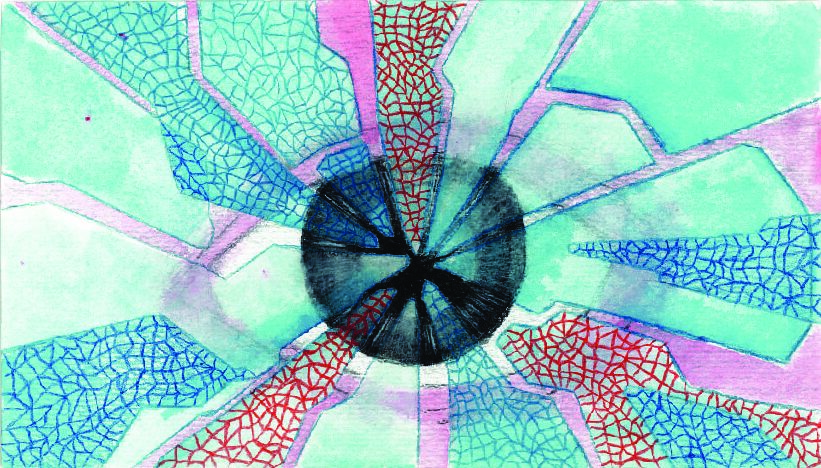
Marsiglia a pezzi
4. Rimpianti
Un racconto di Gaudenzio Schillaci
A cura di
☝🏻 Abbonati a Ratpark Magazine
☝🏻 Condividi se ti è piaciuto!
Rimpianti.
La temperatura è scesa vertiginosamente e ho la sensazione che la televisione si sia fatta meno rumorosa, quasi rassegnata. Mostra immagini dei primi soccorsi, si intravede qualcuno che piange sullo sfondo, altri sono catatonici. Qualche stronzo di opinionista ciarla, ma io il francese continuo a non capirlo. Regna un’atmosfera strana, qui dentro. Persino le mosche sembrano ronzare sottovoce attorno al mio bicchiere. Eppure noi, perduti al di là di un bancone, siamo indifferenti a quello che succede nel mondo fuori da qui. Nemmeno Adil sembra scomporsi più di tanto. La sua vita è quella lì e sembra sicuro che lo rimarrà ancora a lungo, con buona pace di attentati e attentatori.
Questo tizio che mi siede di fronte mi guarda in faccia in attesa della mia prossima mossa, con un malcelato senso di soddisfazione per avermi rifilato uno scacco matto, sembra quasi volermi dire “e adesso che farai?”, con il modo in cui mi guarda.
Non lo so cosa farò, davvero. Non so cosa dirgli. Non so come agire. Non so cosa pensare. Non so se è il momento di lanciargli un tavolino addosso e iniziare a correre, non so se devo prendere una bottiglia e schiantargliela sulle tempie, non so se è il caso di chiedergli spiegazioni. Restiamo in un silenzio di cristallo per un tempo che non saprei quantificare, ma di certo a lungo.
È dunque con una netta sensazione di ineluttabilità che faccio cenno ad Adil di prepararmi un altro pastis: siamo sull’orlo del baratro, e non posso fare nulla per evitare di caderci dentro. Almeno, penso, non lo farò con la gola secca.
Dal tavolino dietro di noi parte una canzone, viene fuori dal cellulare di uno dei neri. Una musica dai suoni quasi jazz su cui si inerpica una voce netta, tagliente come una lama ben affilata, che sputa parole sempre con la stessa cadenza.
“This is the number one rule for your set, in order to survive, got to learn to live with regrets”
Uno di quei tre canta appresso alla musica mentre gli altri due muovono la testa a ritmo.
Regrets. Rimpianti. Per sopravvivere, devi imparare a convivere con i rimpianti. Quel ritornello mi si infila nel cervello e sembra non volerne uscire. Adil mi mette sotto al naso il mio bicchiere e l’odore dell’anice quasi mi stordisce. Devo provare a capire chi è l’uomo che mi siede accanto o reagire? Lasciarmi trascinare da lui in un gioco che chissà come finirà o provare a salvarmi il culo? Devo imparare a vivere con i rimpianti, ecco cosa. Ha ragione quella canzone. Non so chi la canta, credo sia Jay-z, la voce pare la sua. Ho la sensazione che questo sia il momento in cui devo scegliere quale rimpianto portarmi appresso, per sempre.
«Come fai a conoscere Anna?», mi viene fuori dalla bocca. Forse la voce ha tremato un po’, questa situazione mi intimorisce e mi fa star male, ma non posso più starmene zitto.
Lui ridacchia, mentre si lancia in bocca il fondo della sua Bud.
«Non è importante, diciamo che la conosco e basta, caro… Fabrizio», conclude, e nel farlo mi mette una mano sulla spalla, un gesto a metà tra il bonario e il minaccioso.
Capisco bene cosa sta succedendo. Sa di me e del mio segreto. Sa chi sono. E no, non sono un Fabrizio qualunque. Com’è possibile che lo sappia, non è dato saperlo. E io, inoltre, non conosco nulla di lui. Questo mi mette in una evidente posizione di svantaggio: non riesco a leggere nessuna delle sue prossime mosse, né a capire le sue intenzioni. Decido di tagliare corto. Devo solo trovare un modo per andarmene da qui e tornare in quel cesso di seminterrato e dimenticarmi di ogni cosa. Se fosse possibile, anche di me stesso.
Faccio un sorso e cerco di tirare fuori tutto il coraggio di cui sono a disposizione. Indosso la maschera del duro.
«Chi cazzo sei e che cazzo vuoi da me?»
Quello ride. Mi ride in faccia, così, sguaiato, senza porsi un freno.
Contraggo la mascella, cercando di darmi un tono, di accentuare l’aggressività.
«Non sono qui per te, tu sei… diciamo un effetto collaterale. Secondo te mi metto a perdere tempo a rovistare nella spazzatura, io? Però una cosa voglio dirtela: rimettiti le palle in tasca e vedi di tornartene a casa. Questa città non fa per te»
Tira fuori un biglietto da cinquanta, lo appoggia sul bancone. «Il resto è mancia», urla, prima di andarsene.
I tre neri stanno ancora a smuovere il capo al ritmo di musica: occhi socchiusi smarriti sul fondo di cappucci di felpa, labbra che si allungano in un abbozzo di sorriso. Adesso hanno messo un lento e sembrano sognare, su quei suoni che paiono fatti di miele e nuvole.
Ha un effetto balsamico anche su di me. Mi tranquillizza, chiudo gli occhi anch’io e mi lascio trascinare lontano, non so dove, nel ventre di un mare placido, al centro esatto di un mondo dove nulla può farmi male. Né a Marsiglia, né a casa mia. Lì dove nessuno può trovarmi.
La voce che viene fuori dal cellulare di uno di quei tre inizia a gorgheggiare, si alza di tono, prende un retrogusto nevrotico, elettrico, e continua a ripetere “marry me, marry me, marry me”, “sposami, sposami, sposami”, e continua e non smette, “marry me, marry me, marry me…” fino a sfumare e scomparire, e insieme a lei scompare la quiete e ritorna la realtà, ritorno a Marsiglia, tra le viscere molli di Chartreux, ritorno dentro al bar, ritorna il pastis tra le mie mani, ritorna l’angoscia di quello che è appena successo e io ritorno ad essere non semplicemente da solo ma nel cuore esatto della solitudine.
Una solitudine sconfinata, la mia: quella di una vita nascosta, appena nata e già morente, in una città attraente e sconosciuta che mi seduce e mi confonde, ancora e ancora, trascinandomi ai suoi fianchi per ballare un lento che profuma di menta, di salsedine, di promesse che non verranno mai mantenute.
Devo rimettermi in piedi, in qualche modo. Saluto Adil, passo a fianco al tavolo di quei ragazzi e mi viene da chiedergli il titolo di quella canzone.
«Chanson, title…», sbiascico.
Uno di loro tira fuori la testa dal cappuccio, mi guarda strano, come se avessi osato interrompere una liturgia, un rito. Come avessi bestemmiato in chiesa.
Poi, lentamente, mi risponde.
«C’est R. Kelly, mon freeère…The Pied Piper of R’n’B», dice. In mezzo alle labbra gli brilla un dente lucido, di metallo, forse oro.
Lo ringrazio con un mezzo sorriso, e lui si batte la destra sul petto. Infine, mi tiro fuori da lì dentro.
Passo la notte a rimuginare, ma i pensieri si accatastano uno sopra l’altro, senza alcuna forma di ordine. Non riesco a dormire. E se Anna fosse in pericolo? Io me la saprò cavare, in qualche modo, e se anche dovessi morire a nessuno importerebbe, forse sarebbe persino giusto che lo facessi, insomma avrei delle colpe a riguardo, ma lei? Non è stata capace di amarmi come avrei voluto, certo, e non è stata disposta al sacrificio per un eventuale “noi”, ma come avrebbe potuto farlo, del resto?
Non siamo più quel tipo di società, il mondo è cambiato e al centro di ogni ragionamento è stato messo l’io, la soddisfazione personale, la convinzione egoriferita che tutti possono sempre ottenere quello che desiderano. Che prima viene la persona, dopo gli altri. Il pensiero che tutto può sempre accadere, nel mondo delle infinite possibilità. Un’infinita bugia.
La sua sola colpa è quella di appartenere ad una vera e propria generazione sacrificata, incapace di amare, incapace di amare di un amore vissuto con innocenza e con la capacità di illudersi ancora. Disabituata all’idea del sacrificio per qualcun altro. Lei non si è mai sacrificata per me: la sua presenza nella mia vita è sempre stata intermittente, liminale, distante giusto un passo dal definitivo tradimento.
Eppure, è abbastanza per meritarsi l’eventualità del pericolo? No, mi dico, non che non lo è. Lei è una scintilla e le scintille si accendono e si spengono da sole. Non potrei mai perdonarmi se qualcuno, a causa mia, le facesse del male. Per questo devo cercare di restarle fedele: perché, lei è un’ideale, per me, prima ancora che la mia persona. E gli ideali si difendono fino alla morte.
Sento che il cervello mi sta andando fuori giri, ho le braccia stanche e le gambe che tremano. Forse i miei ragionamenti sono tutte cazzate, nessuno è in pericolo, né io, né Anna, né Walid, e magari quel tipo lì, quell’Andrea, è solo un coglione che per caso è venuto a sapere dei miei documenti falsi, o più plausibilmente uno stronzo di scagnozzo di Abarth che vuole darmi un avvertimento, adesso che pare siamo entrati in affari. Chissà, magari sono stupide anche tutte quelle mie riflessioni sull’amore, sui motivi per cui tra me e lei non ha funzionato, magari più semplicemente lei non si è mai innamorata di me e basta, fine dei giochi. Solo infatuazione. Giusto una buona compagnia, e qualche buona scopata.
Momenti che per me avevano un senso e per lei erano invece solo una finzione tra tante. Nulla da imputarle. Nulla per cui essere risentiti. “Magari”, “chissà”, “forse”. Sono stanco di tutte queste ipotesi. Sono stanco di essere così solo da dovermi costringere ad analizzare il passato. Da dover fare la conta di ogni fallimento, l’analisi di ogni sconfitta, l’elenco di ogni rimpianto. “Bisogna imparare a conviverci”, diceva quella canzone che ho sentito al bar.
E io non mi sento di essere sulla strada giusta. Il buio di questo scantinato è di una violenza insostenibile. Mi ritorna in mente l’altra canzone che avevo sentito prima, quell’appello disperato al matrimonio, quel “marry me” ripetuto infinite volte. Anna non scompare mai dai miei pensieri, e adesso è come se sentissi la sua voce che canta, e canta, e canta… “Marry me”, “marry me”, “marry me”, non smette di cantare, coi suoi grandi occhi neri che mi inghiottono e cancellano ogni residuo di malessere. Piano piano, scivolo dentro a un sonno accogliente.



