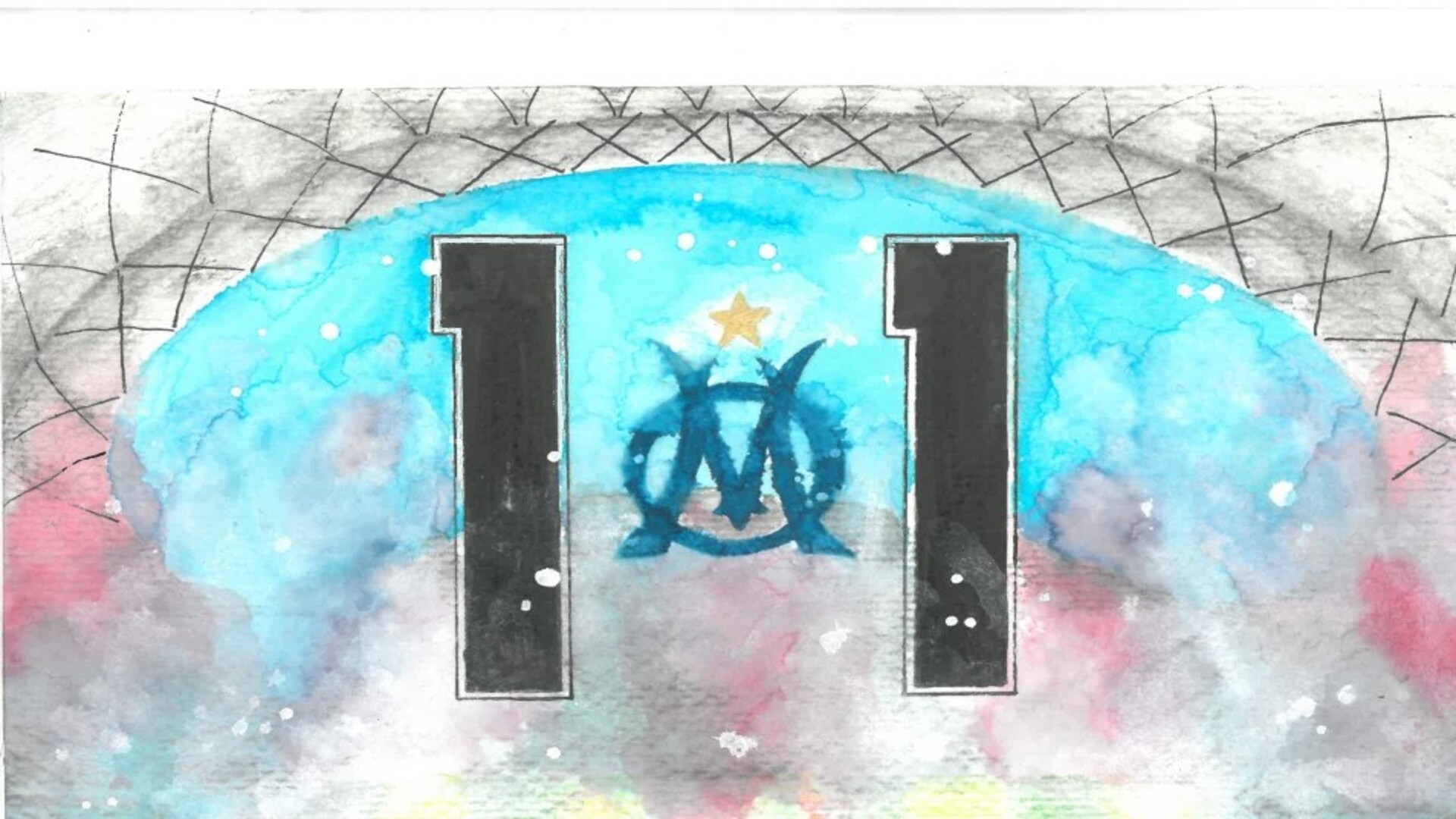
Marsiglia a pezzi
1. Ravanelli
Un racconto di Gaudenzio Schillaci
A cura di
☝🏻 Abbonati a Ratpark Magazine
☝🏻 Condividi se ti è piaciuto!
Ravanelli.
Avevo chiesto un pastis al bancone e poi, dopo, Adil me ne aveva allungato un altro senza chiederglielo. Dal terzo in poi avevo, come ogni volta, perso il conto.
«Cette année l’OM no fa mai gol», mi dice nel suo italiano claudicante. L’aria di mare arriva fino a qui, sui tavolini del Bar de la Poste, in Rue Pierre Roche. Di solito a Chartreux il mare è solo un miraggio a portata di metropolitana, e invece oggi mi sembra quasi di essere seduto sulla Quai du Port, magari affacciato dalla terrazza del La Samaritaine. La più bella di tutta Marsiglia. O almeno, la più bella che ho avuto modo di vedere. Il fatto che io venga spesso accompagnato da Walid lo autorizza a credere che anch’io faccia parte della Virage, quindi mi parla sempre della squadra, dell’ultima partita, dell’infortunio del difensore o di quello dell’attaccante. Mi spiacerebbe confessargli che a me dell’Olympique, con tutto il dovuto rispetto, non me ne frega un cazzo. In lontananza risuonano le sirene della polizia prima, poi di un’ambulanza.
Caccio via quei pensieri e gli rispondo che sì, quest’anno l’OM fa proprio cacare. “Faire merde”, gli ripeto, e lui capisce. Almeno credo.
Pago quello che c’è da pagare e scalpito verso l’Intermarché sul Boulevard de la Federation: un quarto d’ora prima che chiuda, come faccio sempre da due mesi a questa parte, così da poter fare razzia di tutta quella merce in scadenza che a quest’ora viene data via alla metà del prezzo.
Torno a casa anche se, per chiamarla così, “casa”, ci vuole un esercizio di coraggio non da poco. Sempre meglio di vivere in strada, certo, ma resta lo stesso uno scantinato umido con un divano letto al centro, un frigo, un lavabo e un cesso alla turca, qualche scatola dove nascondere quei pochi vestiti che mi ha passato Walid e dove l’unico passatempo a mia disposizione è leggere un libro seduto vicino all’interruttore della luce, tarato in modo da spegnersi ogni due minuti e che ogni due minuti va riacceso.
Ma tra poco tutto questo finirà.
Domattina i miei documenti saranno pronti, diventerò Fabrizio. Un nome come tanti per quello che sarà un italiano come tanti altri, in questa città. Avrò un passato, forse persino un futuro, non soltanto questo intramontabile presente che ho vissuto negli ultimi due mesi. Dovrò ringraziare ancora Walid, che si è dimostrato quello che è: un uomo pieno di senso di appartenenza. Al giorno d’oggi, non è poi così scontato. Mi metto a dormire coccolato da questi pensieri, finalmente dolci. La vita del ratto, del sottosuolo, sta per concludersi, e senza nemmeno accorgermene si è già fatta mattina, si è già fatta l’ora di andare a prendersi il domani. Mi do una rinfrescata e sono pronto.
Poche fermate di metro e scendo a La Fourragere. Walid mi sta aspettando. Scambiamo chiacchiere e convenevoli, con lui posso parlare tranquillamente, il suo italiano è pressoché perfetto, leggermente innaffiato da una leggera cadenza francese. Sembra sinceramente felice per me, che finalmente posso andarmene via dallo scantinato di Melody, “la sua seconda puttana preferita”, ecco come mi dice. “La seconda”. La prima, non ha mai voluto presentarmela. Né a me né a nessun altro. Nemmeno ad Abarth. Non c’è nessuno, in tutta Marsiglia, che abbia mai avuto il piacere di conoscerla.
Qualche minuto dopo, ci infiliamo in un vicolo su Boulevard Gasquy.
«Siamo arrivati», mi fa, tutto tronfio, quasi orgoglioso. Scosta un portone di metallo pesante, completamente ricoperto da parole scritte allo spray, e ci infiliamo dentro uno stanzone buio che puzza di rancido. Piscio e sudore insieme. Un ring al centro, sacchi appesi un po’ ovunque, musica araba risuona in lontananza. Si muove con assoluta determinazione, non semplicemente come qualcuno che conosce un posto, piuttosto come qualcuno che ne fa pienamente parte, che lo riconosce come suo.
Parla in arabo, a voce alta. Credo si stia facendo riconoscere.
Un gigante viene fuori da una porticina in fondo alla sala.
«Ravi de vous rencontrer, ils m’ont beaucoup parlé de toi», mi dice allungandomi la mano. Gliela stringo e gli sorrido, anche se non ho capito nulla di quello che ha detto.
«Il ne parle pas français», gli fa Walid.
«No problema, palliamo… italien», mi guarda. Non ha certo uno sguardo affettuoso, anzi, ha proprio l’aria di uno abituato a comandare. Eppure, si mostra accogliente, si sforza di farsi capire e tutto sommato ci riesce, seppure il suo italiano non sia ottimo come quello del mio accompagnatore. Trovo sorprendente il fatto che qui siano tutti poliglotti, che abbiano dei rudimenti di almeno quattro o cinque lingue diverse. Probabilmente è merito delle migrazioni che in questa lingua di terra ci sono sempre state, anzi, è sicuramente così: ma non credo sia soltanto questo, il motivo. Penso piuttosto che questa città, nata sul mare, sia però poi cresciuta nelle strade, nei vicoli, in quei quartieri pieni di palazzoni dove si va tutti allo stesso bar, tutti allo stesso supermercato, tutti nella stessa piazza. È una necessità primaria, allora, quella di comprendere l’altro, di trovare un punto in comune. Istinto di sopravvivenza. Portoghesi, spagnoli, italiani, arabi, francesi: in qualche modo, bisogna pur capirsi. Bisogna pur imparare a sopravvivere. E a condividere tutto questo sole.
Il gigante continua a parlare e alla fine concludiamo l’accordo: gli metto in mano una busta con duemila e cinquecento euro e in cambio lui me ne dà un’altra con dentro il mio nuovo nome, una bella carta d’identità marchiata Municipalité de Marseille e una patente nuova di zecca.
«Allora ciao, Fabrizio», mi congeda.
Dovrò abituarmi in fretta a sentire quel nome, “Fabrizio”.
«Come Ravanelli!», ridacchia Walid, mentre ci incamminiamo verso la stazione della metro.
Non ricordavo nemmeno che Ravanelli avesse giocato qui, e invece non solo lo fece per due anni e mezzo, ma diventò persino un idolo della tifoseria tanto da essere ancora ricordato, un paio di decenni dopo, con immutato affetto.
«Le simulateur», mi racconta. Socchiude gli occhi, sembra quasi sognante, prima di riprendere a parlare. «Novembre 1997, avevo nove anni: la prima volta al Velodrome. Ravanelli corre con il pallone, entra in area, il difensore gli corre dietro, la palla si… allonger, allunga un po’ e lui BOOM, au sol. Rigore. Blanc prende il pallone, tutti i parigini di merda attorno all’arbitro. Blanc segna. Vinciamo 2-1, e il giorno dopo mio padre torna a casa con una maglietta per me»
«Quella di Ravanelli?»
«Oui, la numero 11»
Sorride, sembra quasi essere tornato quel bambino che assaggiava lo stadio per la prima volta.
«Ci furono… come dite voi, controverses, controversìa, per tutto l’anno a causa di quel rigore… Che annata. Sai, per noi che siamo nati qui l’OM è tutto: è fedeltà, è appartenenza, è représentation, rappresentazione di quello che siamo. Francesi, ma fino ad un certo punto. Francesi, ma figli e fratelli del mondo, arabi, marocchini, algerini, ma anche europei, italiani, corsi, spagnoli, sardi. Tu me comprends? Arrivando in città, su uno dei ponti sotto cui si passa venendo dall’aeroporto, c’è scritto “bienvenue dans le sud». Perché questa non è Francia, questo è il Sud della Francia: tutta un’altra cosa»
Prosegue a parlare di come Ravanelli, con quella simulazione, abbia fottuto la Francia intera, la Francia vera, quella del Nord, di come quel rigore abbia rappresentato il loro riscatto dopo la squalifica comminata alla società nei primi anni ’90, quelli della presidenza di Bernard Tapie, quelli dell’unica, fino ad oggi, Champions League vinta da una squadra transalpina. Prosegue e non smette, ma io non lo ascolto più. Siamo su un vagone della metropolitana diretto al Vieux Port e sento il sangue salirmi alle tempie, come un flash sparato dentro agli occhi.
Il viso di Anna. Anna che canta, uno di quei vecchi pezzi jazz che le piacciono tanto. Etta James o Nina Simone. Le vene del collo, ingrossate per fare uscire la voce. Le Supremes. “Baby love, my baby love, I need you, oh how I need you”. Quel collo abbronzato e magro, sottile come il suo sguardo che mi scalfiva la pelle. Un collo che ti veniva voglia di baciare per giorni interi, lì, tra l’orecchio e la mascella. Di accarezzare in punta di labbra, solo per poter sentire la morbidezza della pelle, il suo profumo. La sua voce da Ella Fitzgerald. “Baby, it’s cold outside, I’ve got to go away”. Come potrei mai odiarla, una così? È vero, non ha mai risposto a quel messaggio che le mandai la prima notte a Marsiglia e di lei non ho alcuna notizia da due mesi, ma no, odiare qualcuno che si è amato così tanto non è pensabile, per me. Si è amato o si ama ancora? Forse, si amerà per sempre. Un po’ come Walid, quasi trent’anni dopo, ama ancora Ravanelli per quel rigore che non avrebbe dovuto esserci.
Un po’ come questa città che accoglie tutti, marinai e biscazzieri, turisti e puttane, divi di Hollywood e morti di fame. C’è un pezzo di Marsiglia per ognuno di loro. Li corteggia, questa città, uno per uno, con quel sole che sembra sussurrarti “vienimi a prendere, sono qui, solo per te”. Un po’ come chiunque ha amato anche solo per un attimo la vita, in fondo, non smette mai di amare. “I’ve got to go away”, cantava Ella Fitzgerald. Lo canto anch’io. Anche se fuori, qui, non è per nulla freddo. Non come in quella vecchia canzone.
Siamo arrivati a destinazione. Scalpitiamo lungo le scale sporche della stazione e ci affacciamo su un mare azzurrissimo, lucente. Tutt’attorno gente che cammina, ride, altri seduti ai bistrot che mangiano, bevono, ridono anche loro. Sembra che dalle parti del Vieux Port la tristezza non sia ammessa. In qualche modo riesco a farmi contagiare anch’io e non penso più ad Anna. Mi fermo davanti alle vetrine, in particolare davanti ai negozietti di souvenir, non me ne perdo uno. Walid è sempre al mio fianco. Poi ci infiliamo in un baretto e al bancone chiedo due caffè.
«Espresso», mi corregge lui. «Se chiedi caffè, fanno caffè lungo. Caffè all’italien qui si chiama espresso»
Ecco la prima cosa che ho imparato su Marsiglia nel mezzo del cammino di questa nuova vita.
«Ravanelli, andiamo», mi dice. Ha deciso da ora in poi mi chiamerà così, come il suo idolo d’infanzia. «Il est tard, è tardi»
Mi porta attraverso dei vicoletti pieni di negozi, dietro al Porto, in direzione Panier. Alcuni più curati, altri meno. Appare come un continuo miscelarsi di ricchezza e povertà, questa parte della città. Vetrine illuminate e serrande abbassate che se ne stanno una accanto all’altra. Vicine, ma ben distinte. Unite, ma distaccate. Come acqua e olio. Leggo su una targhetta appesa in un angolo della strada Rue de la Palud. Hotel Monte Cristo.
Mi fa cenno di seguirlo.
All’inizio della ringhiera della scala, un cartello: “Allez l’OM”.
Al terzo piano ci aspetta Abarth, quello che mi ha sempre detto essere il suo migliore amico. Il capoultras della Virage.



